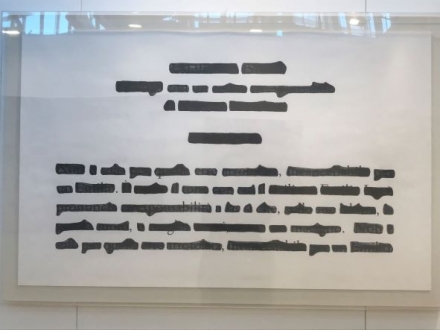J'accuse. L'ufficiale e la spia. Una grande lezione di cinema, un thriller perfetto, un monito contro l'antisemitismo.

J’accuse, Leone d’argento e Gran premio della Giuria all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è innanzitutto una grande lezione di cinema.
Polanski, insieme al direttore della fotografia Pawel Edelman, hanno compiuto un lavoro accuratissimo di ricostruzione storica.
Dal campo lungo della sequenza d’apertura, ispirato all’illustrazione di Henry Meyer per Le petit journal, passando per le riprese processuali, modellate anch’esse sul medesimo giornale; sino ai toni virati seppia di Dreyfus all’Isola del diavolo che citano le stereografie dell’epoca per finire con la ricostruzione di Le déjeuner sur l’herbe di Manet, ogni particolare contribuisce a trasportare lo spettatore nell’epoca storica in cui si svolse l’affaire Dreyfus.
Tutto ciò si innesta su di una struttura che è quella del thriller.
J’accuse, alla fine, è una storia di spie, a partire dal tenente Picquart (Jean Dujardin), che si rendono conto ben presto di come il traditore non sia Dreyfus (Louis Garrel) ma, probabilmente, il maggiore Esterhazy.
Dunque, come ogni spy story che si rispetti, avremo a che fare con pedinamenti, plichi segreti ed agenti impegnati ad aprire le missive private dei sospettati, con l’inevitabile contorno di intrighi e ricatti.
Al centro c’è Picquart, il classico uomo solo contro tutti che si ritrova a dover combattere contro un sistema, stavolta quello militare, deciso ad occultare la verità, nell’eterno scontro tra senso dell’onore del protagonista versus ragione di stato.
Ovviamente J’accuse non è un thriller adrenalinico moderno, possiede piuttosto il respiro dei grandi classici del passato, l’unico possibile per un film storico in costume.
Il modello a cui guardare, ancora una volta, è Hitchcock, omaggiato persino nel piccolo cammeo che si riserva Polanski il quale, si conferma un vero maestro del genere.
A conferma di ciò basterebbero sequenze come quella ambientata nella chiesa, in cui la tensione è creata tramite l’orchestrazione perfetta dei tempi con cui entrano in scena i diversi protagonisti, il tutto sottolineato dagli sguardi di Picquart e dai lievissimi movimenti di macchina che li accompagnano; a Polanski non serve altro per tenere una lezione di come si crei tensione al cinema.
Poi, ovviamente, c’è l’altro livello, quello dei contenuti.
Non parliamo tanto del facile parallelismo tra l’affaire Dreyfus e le vicende giudiziarie di Polanski, sottolineate dal regista stesso nel pressbook del film ed ampliate dalle polemiche scoppiate a Venezia in seguito alla decisone della Presidente di Giuria, Lucrecia Martel, di non partecipare alla proiezione ufficiale del film e di impedire (di fatto) che ricevesse il Leone d’oro.
Questa tesi non ci convince per il semplice fatto che Dreyfus era innocente, Polanski no.
Ci sembra, piuttosto, che il J’accuse del regista riguardi il filo rosso che lega gli ultimi tre secoli, ovvero l’antisemitismo.
Qualora allo spettatore non fosse chiaro, Polanski esplicita il suo messaggio nella sequenza in cui, in seguito alla riapertura del caso Dreyfus, si vede la folla che disegna stelle di David sui negozi, scrive sui muri “morte agli ebrei” spacca i cristalli dei negozi e dà fuoco ai libri di Émile Zola.
Le stesse scene che meno di 50 anni dopo rivedremo nella Germania nazista.
Polanski non fa sconti a nessuno e ci inchioda alle nostre responsabilità storiche individuando nell’antisemitismo il male dell’Europa moderna.
Un’accusa, evidentemente, insostenibile ed inaccettabile per un continente che continua a sottovalutare tale pericolo e che sembra cercare disperatamente l’oblio della memoria e della verità.
Meglio premiare la rivolta qualunquista e populista capitanata da un clown che riconoscere il marchio d’infamia che macchia ancora oggi tutte le nostre coscienze.
EMILIANO BAGLIO